
Issue #09
25 MARZO 2025
— Editoriale a cura di Alfredo Schweiger, Technical Director Federacciai, Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
— LE POLITICHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE – IL CASO DELL’ACCIAIO by ECCO
— KNOWLEDGE PARTNER’S TAKE – Decodificare il panorama italiano del solare e dello storage by pv magazine
— KNOWLEDGE PARTNER’S TAKE – La stagione degli accumuli by Green Horse Advisory
di Alfredo Schweiger, Technical Director Federacciai, Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
La siderurgia italiana ha ridotto le proprie emissioni di CO2 di oltre il 60% dal 1990 ed oggi può vantare un’intensità emissiva per tonnellata di acciaio prodotto che la colloca al primo posto in Europa e tra i primi nel mondo per livello di decarbonizzazione.

Il primato è ottenuto dall’Italia grazie alla elevatissima percentuale di produzione di acciaio tramite ciclo a forno elettrico, tecnologia che, attraverso il riciclo del rottame ferroso e l’utilizzo dell’energia elettrica per il processo di fusione, consente di avere un ridotto impatto emissivo rispetto alla produzione a ciclo integrale, che utilizza come materie prime il minerale di ferro e il carbon fossile. Altri elementi che contribuiscono a questo risultato sono l’elevata efficienza energetica degli impianti siderurgici italiani e un crescente peso delle energie rinnovabili nei consumi elettrici che consente di ridurre progressivamente le emissioni indirette.
La siderurgia italiana si colloca pertanto in una buona posizione di partenza nel percorso verso la neutralità climatica e ha l’ambizione di diventare nei prossimi anni un modello assoluto a livello globale.
Le principali aziende italiane del settore hanno messo in campo programmi ambiziosi in questa direzione che coinvolgono la riduzione sia delle residue emissioni dirette (scope1) sia di quelle indirette (scope 2).[1] Inoltre l’acciaio, materiale estremamente versatile e riciclabile al 100%, è riconosciuto come strategico dalle stesse istituzioni europee, in quanto indispensabile nella realizzazione di applicazioni chiave per la transizione ecologica quali le energie rinnovabili e le reti di trasporto dell’energia; costruzioni e infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico e della sicurezza; mobilità sostenibile e trasporto ferroviario; meccanica e macchinari per la trasformazione tecnologica e l’automazione; sistemi di raccolta e trasporto della risorsa idrica, ecc.
Tuttavia il settore siderurgico nazionale ed europeo, unitamente a gran parte dell’industria manifatturiera, mostra oggi segnali di forte sofferenza e perdita di competitività.
È pertanto urgente chiedersi quali sono le condizioni essenziali affinché un settore strategico come quello siderurgico possa continuare e completare il percorso di decarbonizzazione mantenendo un elevato livello di competitività e redditività, assolutamente vitale in un contesto geopolitico come quello attuale sempre più sfidante e complesso? Riuscirà il Clean Industrial Deal, recentemente presentato dalla Commissione Europea, ad aggiungere la “gamba mancante” del Green Deal in termini di politica industriale e competitività, fino ad oggi gravemente dimenticata dalle istituzioni UE?
Al di là delle intenzioni dichiarate nello Steel and Metals Action Plan, pubblicato di recente dalla Commissione UE, molto dipenderà dalla concretezza delle misure effettive che verranno messe in campo per affrontare i seguenti punti prioritari.
Le acciaierie italiane pagano prezzi dell’energia elettrica sistematicamente superiori, in alcuni casi in maniera molto significativa, non solo rispetto ai competitors internazionali, ma anche rispetto ai concorrenti localizzati in altri stati membri. Nonostante la crescente quota di energia rinnovabile presente nel mix energetico nazionale, il prezzo dell’energia elettrica rimane ancorato ad una fonte fossile come il gas naturale (negli ultimi anni come noto soggetto a forti tensioni e crescenti speculazioni) per effetto del meccanismo di mercato del c.d. “marginal price”. Questo sistema, utilizzato in Italia come negli altri paesi europei, se non ben congegnato non consente di fatto di trasferire ai consumatori (imprese e cittadini) i benefici dell’energia rinnovabile dovuti ai costi operativi ridotti e alla totale assenza di costi del carbonio.
È necessario pertanto esplorare urgentemente tutte le soluzioni possibili, da mirati aggiustamenti al modello nazionale, fino ad una riforma europea dei meccanismi di mercato che produca una diminuzione dei prezzi dell’energia, consentendo in particolare il disaccoppiamento del prezzo dell’energia da fonte rinnovabile da quello del gas naturale o di altre fonti fossili.
Mix differenti di produzione dell’energia nei diversi stati membri, insieme alla mancanza di un sistema elettrico realmente interconnesso, con l’aggravio di incentivazioni lasciate alla facoltà nazionale nella forma dell’aiuto di stato, hanno completamente vanificato fino ad oggi l’idea di un mercato unico europeo dell’energia, portando a rilevanti distorsioni di competitività. È pertanto necessario uniformare a livello europeo gli aiuti, anche attraverso fondi comuni europei e lavorare per realizzare il prima possibile una tariffa unica europea dell’energia elettrica per i settori ad alta intensità energetica esposti alla concorrenza internazionale
Inoltre deve essere garantita la pluralità tecnologica: tutte le leve di decarbonizzazione (non solo le energie rinnovabili) devono essere considerate ed utilizzate senza pregiudizi ideologici, valutando quelle più efficienti ed idonee applicando parametri tecnico/economici per i settori energivori, che hanno bisogno di approvvigionarsi in maniera stabile e continuativa di energia baseload decarbonizzata.
Il riciclo di una sola tonnellata di rottame ferroso consente di evitare l’emissione di una tonnellata e mezzo di CO2, oltre a ridurre drasticamente i consumi energetici e quelli di risorse naturali. La crescente attenzione verso produzioni siderurgiche a basse emissioni di CO2, in UE e nel mondo, porterà a una ripida crescita della domanda di rottame. A livello globale, la percentuale di produzione da forno elettrico, pari attualmente al 29% della produzione totale, potrebbe superare il 41% entro il 2030.[2] La domanda globale di rottame crescerà ad un ritmo superiore alla disponibilità con il rischio di uno shortage critico che andrebbe soprattutto a penalizzare il nostro Paese, che già oggi non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno con la sola raccolta interna. Il rottame ferroso deve essere pertanto definito come una materia prima strategica per la circolarità e la decarbonizzazione e come tale difeso, attraverso misure in grado di aumentarne la disponibilità e la qualità, ma soprattutto contrastandone l’esportazione (paradossalmente in forte crescita negli ultimi anni) a favore di paesi che non garantiscono gli stessi standard ambientali e sociali dell’UE e che non hanno obiettivi climatici paragonabili. Alcuni degli ambiti su cui è necessario intervenire a livello UE sono: normativa sulle materie prime critiche e strategiche; misure commerciali (limitazioni alle esportazioni); attuazione del nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; revisione del regolamento sui veicoli a fine vita.
Il meccanismo CBAM di aggiustamento del carbonio alla frontiera, che agisce in combinazione con la progressiva eliminazione delle quote gratuite ETS per i produttori UE, rischia di essere uno strumento totalmente inefficace o addirittura controproducente, se non verrà profondamente corretto, semplificato e integrato, prima della sua entrata in piena operatività nel 2026. Le semplificazioni recentemente proposte nel c.d. “omnibus package” non affrontano in alcun modo i problemi strutturali dello strumento.
È innanzitutto necessario trovare soluzioni idonee per estendere il meccanismo CBAM alle esportazioni: in assenza di questa correzione, i prodotti europei, gravati di costi CO2 crescenti, si vedrebbero del tutto impossibilitati a competere sui mercati esteri. Inoltre il meccanismo va esteso ai prodotti finiti realizzati con i semilavorati in acciaio, per evitare che il fenomeno del carbon leakage si traferisca semplicemente a valle nella catena di fornitura, vanificando completamente le finalità dello strumento.
Infine il meccanismo di funzionamento del CBAM, già nella fase transitoria, ha dimostrato di essere eccessivamente complicato e allo stesso tempo vulnerabile e va pertanto profondamente semplificato e rafforzato, soprattutto per ridurre le possibilità di aggiramento ed elusione facilmente attuabili dai produttori esteri. In ogni caso, qualora il CBAM si dimostrasse inefficace nel contrastare il rischio di carbon leakage, andrebbe dilazionata l’eliminazione delle quote gratuite nel sistema ETS, consentendo in questo modo alle imprese impegnate nella transizione di completare il percorso di decarbonizzazione senza perdita di competitività.
Una definizione di “green steel” armonizzata appare quanto mai necessaria al fine di rendere riconoscibili sul mercato i prodotti in acciaio con minor impatto climatico (in base a criteri scientifici solidi e condivisi) e poter stimolare in maniera efficace la domanda dei prodotti con la minore impronta carbonica. In questo contesto, soprattutto per settori strategici come quello dell’acciaio, le normative europee e nazionali sugli appalti pubblici (GPP – Green Public Procurement), dovrebbero introdurre criteri minimi vincolanti o classi di performance in grado di spingere la domanda pubblica di prodotti siderurgici “low carbon” (superando il semplice approccio dell’offerta economica più vantaggiosa) ed assegnare al contempo una premialità alla produzione Made in Europe, che deve rispettare standard e obblighi ambientali molto più severi rispetto ai concorrenti extra-UE.
Ciò dovrebbe essere realizzato, per quanto possibile, attraverso un’applicazione semplificata, utilizzando gli standard europei esistenti per la valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti, in modo che tutti i livelli amministrativi, da quello nazionale a quello locale, siano in grado di utilizzarli. Per avere un impatto più significativo nel promuovere la domanda di green steel, questi criteri dovrebbero essere progressivamente estesi anche ai contratti privati.
Per quanto riguarda una possibile classificazione di “green steel” con relativa etichettatura, questa dovrebbe basarsi semplicemente sull’effettiva impronta di carbonio (LCA – Cradle to gate) utilizzando un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico. Al contrario, qualsiasi schema di classificazione artificiosamente costruito sulla cosiddetta “sliding scale” del rottame (come l’etichetta LESS – Low Emission Steel Standard recentemente sviluppata in Germania) non è accettabile, perché agisce contro gli obiettivi dell’economia circolare dell’UE, disincentiva illogicamente l’uso del rottame ferroso e soprattutto svantaggia ingiustamente la tecnologia più sostenibile oggi disponibile per la produzione di acciaio (forno elettrico ad arco), un processo completamente circolare ed elettrificato, che oggi copre oltre l’85% della produzione italiana di acciaio.
[1] Per approfondimenti si veda: Federacciai – Rapporto di Sostenibilità 2023
[2] “Shortfalls in scrap will challenge the steel industry” – Boston Consulting Group 2024
Il programma conference di NetZero Milan 2025 è online, scoprilo e partecipa!
Con l’avvio del suo nuovo mandato, la Commissione ha messo al centro della propria azione la necessità di riconciliare la propria strategia di rilancio competitivo con quella di decarbonizzazione. Il Competitiveness Compass, dello scorso 28 gennaio traccia le linee di questa strategia che passano per la riduzione delle dipendenze strategiche e il rafforzamento del legame tra competitività e decarbonizzazione.
In linea con questi principi, il 19 marzo è stato pubblicato lo Steel and Metals Action Plan, il piano settoriale dedicato ad acciaio e metalli che si inserisce all’interno del quadro del Clean Industrial Deal (CID). Il CID, pubblicato lo scorso mese, mette in luce le azioni a livello UE che si dovranno mettere in atto per proteggere l’industria UE e proseguire nel percorso di decarbonizzazione, attraverso misure che affrontino i costi dell’energia e la forte pressione competitiva internazionale. Lo Steel and Metals Action Plan definisce standard per sostenere la domanda interna per i metalli e il rottame e identifica strumenti abilitanti per la transizione all’idrogeno verde. Quello che la strategia UE non può mettere del tutto a fuoco, sono le possibilità di integrazione che il mercato unico offre, mancando di evidenziare le sinergie e le maggiori possibilità che deriverebbero da un maggiore coordinamento delle strategie nazionali.
In questo senso, l’annunciata presentazione della strategia industriale[1] nazionale, attesa con la pubblicazione del Libro Bianco da parte del MIMIT, si presenta l’ulteriore opportunità di definire un piano di trasformazione industriale che coniughi la salvaguardia della competitività con la decarbonizzazione del settore manifatturiero e che possa, effettivamente, meglio cogliere i vantaggi di una integrazione nel mercato unico a livello delle singole filiere, in cui la governance del progetto del Governo si inquadra.
Questo ampio e diversificato quadro, rende la complessità del momento storico rispetto alla salvaguardia della competitività europea, che sia in grado di preservare le basi del modello socio-economico europeo e gli obiettivi di protezione dell’ambiente e del clima.
L’acciaio è tra i comparti più rilevanti della manifattura italiana: con 21,1 milioni di tonnellate annue (2023), l’Italia è il secondo produttore di acciaio in Europa e l’undicesimo a livello globale[2].
L’acciaio riveste un ruolo fondamentale nelle catene del valore dell’economia nazionale. Grazie alla sua forte specializzazione nell’industria meccanica, l’Italia è il secondo Paese in Europa per consumo di acciaio, con 23.5 Mt nel 2023. L’acciaio in Italia trova il suo principale utilizzo nel settore delle costruzioni (36,5%), seguito dalla meccanica (20,2%), dai prodotti in metallo (18,7%), dal settore automobilistico (17,1%), e in altri settori (il rimanente 7,5%). I prodotti lunghi vengono prevalentemente utilizzati nel settore delle costruzioni, e i prodotti piani, invece, prevalentemente nella meccanica e in automotive.
Per soddisfare tale domanda, l’Italia dipende fortemente dalle importazioni, specialmente di prodotti piani, il cui disavanzo commerciale netto nel 2023 è stato di 6.5 Mt (8.1 Mt nel 2022). L’Italia è il quarto importatore mondiale di acciaio (in volume), ma solo sesto per quanto riguarda le esportazioni. Esiste, quindi, un saldo netto negativo della bilancia commerciale di acciaio di 2.6 Mt per il 2023, un dato negativo da 9 anni consecutivi e in crescita strutturale dal 2014, se si restringe l’analisi ai Paesi extra-UE, da poco meno di 2 Mt a oltre 7 Mt nel 2023.
A questo saldo negativo contribuisce il fatto che negli ultimi 10 anni la siderurgia Italiana primaria, ovvero da minerale, ha registrato un forte declino, con occupati diretti scesi da 36.000 a meno di 31.000 (-15,5%) e l’unico impianto oggi attivo a scala nazionale per la produzione di acciaio da minerale è il sito dell’ex-ILVA, la cui produzione è continuata a diminuire anche nel 2024, raggiungendo i minimi storici con la produzione di poco più di 2 milioni di tonnellate[3]. L’Italia è, però, il maggior produttore europeo di acciaio con forno elettrico (Electric Arc Furnace, EAF). L’86% del totale della produzione di acciaio nazionale parte dal riciclo di rottame d’acciaio, quindi, da materiali di recupero, con minore dispendio energetico e impatto emissivo. Per questa ragione, la produzione nazionale di acciaio italiana è tra le più efficienti a livello globale, con fattori di emissione per tonnellata di prodotto grezzo significativamente inferiori rispetto alla produzione di acciaio da minerale con tecnologia a BF-BOF a carbone (Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace, con circa 2,3 – 2,5 tCO2/tacciaio nel ciclo BF-BOF a carbone contro circa 0.08 – 0.09 tCO2/tacciaio dell’EAF).
La produzione di acciaio è tra le più esposte alla competizione globale, a causa dell’elevata incidenza dei costi energetici sul costo del prodotto finale, in un contesto di costi energetici elevati rispetto ai concorrenti internazionali. A questo si aggiunge la presenza di sovracapacità globale stimata a più di 611 milioni di tonnellate (2023) e che ci si attende possa ulteriormente aumentare con 124 milioni di tonnellate di nuova capacità in corso di realizzazione tra il 2024 e il 2026. La gran parte di questa capacità addizionale sarà localizzata specialmente in India e basata sul processo BF-BOF. Nel resto del mondo, invece, la produzione si sta spostando verso i forni elettrici.[4].
Inoltre, l’introduzione da parte degli Stati Uniti dei dazi all’importazione del 25% su acciaio e alluminio il 12 marzo 2025 non solo avrà un impatto negativo sui produttori dell’UE, limitando l’accesso al mercato statunitense, anche per i metalli di base trasformati in prodotti a valle, ma aumenterà anche la pressione derivante dalle esportazioni precedentemente destinate agli Stati Uniti, che potrebbero essere reindirizzate verso l’UE.
In un contesto internazionale così complesso, il processo europeo di decarbonizzazione può fornire una importante chiave di lettura nel rilancio della competitività dell’industria dell’acciaio italiana. Da una parte puntando alla creazione di mercati dedicati ai beni ‘verdi’, dove la ridotta intensità emissiva della produzione nazionale costituirebbe un significativo vantaggio competitivo, dall’altra intervenendo per ridurre gli elevati costi dell’energia elettrica, che ad esempio in Italia è gravata da componenti fiscali e parafiscali particolarmente elevate.
Nel contesto dell’attuazione delle politiche europee di decarbonizzazione e competitività, è evidente la necessità di un approccio integrato delle politiche che possa accompagnare il settore acciaio attraverso la transizione, guardando a tutta la filiera e alle implicazioni rispetto al sistema energetico, economico e sociale. Le sole politiche ‘tecnologicamente neutrali’, come l’EU ETS, non possono essere le sole attuate[5].
Le strategie industriali delle maggiori economie mondiali sono, infatti, composte di pacchetti di politiche strettamente integrate e che contemperano politiche fiscali, che favoriscono la produzione interna, commerciali, per penalizzare comportamenti anticoncorrenziali, economiche estere per garantire le catene di approvvigionamento[6].
E’ necessario, quindi, concepire un insieme di politiche industriali a cui assegnare diversi gradi di priorità e da coordinare nella loro esecuzione, come anche proposto nello studio Politiche per la trasformazione industriale – il caso dell’acciaio.
Le politiche di sostegno all’offerta dovrebbero aggredire i costi di investimento, anche nell’ottica di stimolare la domanda interna di tecnologie abilitanti, anch’esse prodotte in Italia ed Europa, ma non solo. Per affrontare i costi energetici elevati, è necessario implementare politiche che garantiscano prezzi stabili e competitivi per l’elettricità, come i contratti per differenza (CfD) e i Power Purchase Agreements (PPA), e incentivare il più possibile l’aumento e la penetrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico a prezzi competitivi, tutti aspetti evidenziati nel Action Plan for Affordable Energy recentemente pubblicato dalla Commissione. Le sole misure tecnologicamente neutrali, come l’EU ETS che disincentivano processi ad alta intensità emissiva, possono contribuire a favorire la decarbonizzazione, ma non sono sufficienti e rischiano di risultare punitive se non sono accompagnati da iniziative volte a incentivare un’alternativa a basse emissioni, che inevitabilmente dovrà focalizzarsi sulla tecnologia con il miglior rapporto costo-efficienza, cioè l’elettrificazione.
In parallelo, occorre introdurre meccanismi di incentivo e di protezione dal lato della domanda, per favorire lo sviluppo di un mercato che possa costituire uno sbocco alle più costose produzioni di acciaio ‘verde’, per i segmenti di mercato in cui questo è necessario. I maggiori costi dell’acciaio ‘verde’, si ‘diluiscono’, infatti, in produzioni ad alto valore di cui l’acciaio è solo un componente. È , quindi, necessaria, un’accurata valutazione del costo e del beneficio dell’introduzione di standard o mercati per favorire determinati prodotti. Necessario anche far sì che ci sia chiarezza nella definizione di acciaio ‘verde’ e che le prossime proposte per standard in questo senso, seguano un approccio di proporzionalità e rilevanza rispetto al contributo emissivo delle varie fasi di produzione e tengano correttamente conto del contenuto di riciclato.
Meccanismi di supporto alla domanda, devono essere immaginati anche per la produzione di acciaio secondario a partire da rottame ferroso. A dispetto del minore contributo emissivo delle produzioni basate su rottame, infatti, il volume di rottame utilizzato in EU sta diminuendo per due fattori: scarsa domanda interna e prezzi elevanti, spesso causati da una domanda estera sostenuta da pratiche commerciali scorrette o sussidi (cfr. A European Steel and Metals Action Plan). Standard minimi di contenuto di riciclato in prodotti che utilizzano l’acciaio, congiuntamente a strumenti di difesa commerciale, possono aiutare ad ovviare gli attuali problemi di costo del rottame ferroso.
In un momento di tensioni competitive globali, come quello attuale, misure di protezione delle produzioni più efficienti a livello EU deve anche essere garantito. In questo senso, la prevista revisione del meccanismo del Carbon Border Adjustment Measure è auspicabile, tuttavia, la complessità attuativa del meccanismo e le possibilità di elusione della norma, destano preoccupazioni soprattutto per le filiere della trasformazione dei metalli.
Un’azione coordinata tra il livello europeo e nazionale è necessaria. Se l’industria europea si muove collettivamente verso il recupero del divario di innovazione e produttività è possibile attuare un’azione efficace. In quest’ottica lo sviluppo della strategia nazionale e, contemporaneamente, di quella europea è un’occasione da non perdere. L’azione europea beneficerebbe di un maggiore contributo e coordinamento delle prospettive nazionali: a questo livello sono più evidenti le interdipendenze e le sinergie dei sistemi produttivi. Strategie europee, viceversa, possono essere efficaci solo se incardinate su bisogni comuni e complementari degli stati nazionali in relazione al tessuto economico e produttivo di ciascuno, per sfruttare al massimo il beneficio del mercato unico.
[1] “Made in Italy 2030 – Libro verde per una nuova strategia di politica industriale per l’Italia“, MIMIT (2024) https://www.mimit.gov.it/it/libro-verde
[2] Worldsteel (2024), World Steel in Figures 2024, World-Steel-in-Figures-2024.pdf
[3] Ex Ilva, nel 2024 produzione a picco – Corriere di Taranto
[5] Technology-neutral vs Technology-specific Policies in Climate Regulation: The Case for CO2 Emission Standard
[6] Draghi report, 2024 https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
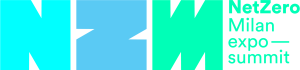
di pv magazine


In occasione del prossimo evento NetZero Milan organizzato da Fiera Milano, pv magazine e Green Horse Advisory presenteranno congiuntamente due sessioni verticali sullo sviluppo delle imprese del fotovoltaico e dell’accumulo di batterie nello scenario energetico italiano. Relatori nazionali e internazionali illustreranno le sfide e le opportunità che investitori, sviluppatori e imprese ad alta intensità energetica devono affrontare nei loro sforzi di decarbonizzazione. Le discussioni saranno incentrate anche sul ruolo delle tecnologie e dei prezzi nel processo di investimento.
Secondo il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Cambiamento Climatico (PNIEC), l’Italia dovrebbe aggiungere oltre 50 GW di nuova capacità solare entro il 2030. Alla fine dello scorso anno la capacità solare del Paese era di 37,08 GW, dopo una crescita di circa 7 GW nel 2024. Per raggiungere l’obiettivo al 2030, il Paese dovrebbe installare circa 10 GW all’anno.
Questo compito impegnativo richiederà uno sforzo notevole. Tutte le parti interessate dovranno acquisire una conoscenza approfondita della catena di fornitura globale del fotovoltaico e delle dinamiche geopolitiche ed economiche che ne sono alla base. L’industria manifatturiera del fotovoltaico non solo sta attraversando un altro ciclo di consolidamento, ma sta anche sperimentando cambiamenti tecnologici, con nuove architetture di celle e moduli che potrebbero destabilizzare l’attuale scenario tecnologico.
Con la riduzione dei costi di produzione e la tendenza al rialzo dei prezzi dei moduli, da tempo attesa, la comprensione delle tecnologie delle celle e dei moduli è fondamentale per la ricerca dei prodotti migliori al prezzo più basso, sia per gli impianti fotovoltaici su tetto che per quelli a terra. La Commissione Europea sta cercando di sostenere i produttori nazionali di fotovoltaico, il che significa che un’industria solare recentemente sovvenzionata potrebbe presto vedere la luce nel Vecchio Continente, con sviluppatori e investitori tenuti a valutare la qualità e il prezzo dei prodotti solari realizzati nell’UE.
Nonostante le turbolenze geopolitiche e il cambiamento delle priorità a livello europeo e globale, l’interesse per le installazioni solari rimane molto forte in Italia. Questo perché il solare fotovoltaico rimane la fonte di energia più economica del Paese.
I recenti cambiamenti politici, del resto, non hanno scoraggiato gli investimenti in progetti solari in Italia, dato che molti impianti sono già pronti per essere costruiti, e un nuovo schema di sostegno – il FerX – dovrebbe fornire nuovo slancio, in particolare nel Sud, nonostante i premi regionali aggiuntivi che premiano installazioni nel Nord.
Nel frattempo, le installazioni nel Nord dovrebbero essere sostenute da un aumento dei contratti di acquisto di energia (PPA), che consentono di mitigare le oscillazioni geopolitiche dei prezzi dell’energia. Questi schemi dovrebbero guidare lo sviluppo del mercato fino alla fine di quest’anno, prima di contribuire a una crescita ancora più pronunciata all’inizio del 2026.
Tuttavia, sono ancora diverse le sfide da affrontare. L’inflazione elevata, i tassi di interesse e i costi di installazione che rappresentano una quota crescente dei costi di progetto continuano ad avere un impatto sugli installatori solari C&I e sugli appaltatori EPC. Rimangono inoltre dei punti interrogativi sulla capacità degli sviluppatori di soddisfare la domanda di nuovi progetti a causa delle difficoltà nel superare gli sviluppi legislativi, le resistenze locali e i difficili scenari di finanziamento.
Con l’aumento della capacità fotovoltaica installata, l’accumulo di energia entra in scena come un altro pilastro della transizione energetica italiana, soprattutto dopo che il governo ha definito il nuovo meccanismo d’asta Macse per le batterie di grandi dimensioni. In quest’ottica, e mentre il business case per i progetti di accumulo collegati al fotovoltaico su tetto diventa sempre più forte, gli installatori e gli EPC sono ora impegnati a identificare i migliori fornitori di tecnologia e i design ottimali delle batterie per rendere i progetti bancabili, indipendentemente dalle loro dimensioni.
La comprensione dei nuovi quadri legislativi e le discussioni in corso su come migliorare le disposizioni per tutti i tipi di sistemi di accumulo saranno fondamentali per aiutare gli investitori e gli sviluppatori a ottenere permessi e finanziamenti, soprattutto perché l’idroelettrico con pompaggio e altre tecnologie meccaniche, come l’aria compressa, potrebbero aumentare il loro peso.
di Green Horse Advisory


In occasione del prossimo evento NetZero Milan organizzato da Fiera Milano, pv magazine e Green Horse Advisory presenteranno congiuntamente due sessioni verticali sullo sviluppo delle imprese del fotovoltaico e dell’accumulo di batterie nello scenario energetico italiano. Relatori nazionali e internazionali illustreranno le sfide e le opportunità che investitori, sviluppatori e imprese ad alta intensità energetica devono affrontare nei loro sforzi di decarbonizzazione. Le discussioni saranno incentrate anche sul ruolo delle tecnologie e dei prezzi nel processo di investimento.
I piani di decarbonizzazione dell’Italia richiederanno un ampio uso di energie da fonti rinnovabili, soprattutto da fonte eolica e fotovoltaica, e imporranno un ricorso massivo ai sistemi di stoccaggio sia di tipo giornaliero che stagionale. Per queste ragioni, negli ultimi anni la ricerca sui sistemi di accumulo ha subito un forte impulso a livello di finanziamenti e il volume di mercato globale di accumulo energetico è quasi triplicato nel 2023.
Di recente la Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, un piano italiano da 17,7 miliardi di euro per sostenere la costruzione e il funzionamento di un sistema centralizzato di stoccaggio dell’energia elettrica. Il regime notificato dall’Italia sosterrà la costruzione di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica con una capacità congiunta di oltre 9 GW/71 GWh.
A fronte di questi obiettivi ambiziosi, tutta la filiera dell’energia si sta attrezzando per ricorrere alle tecnologie migliori e al miglior prezzo seppur in uno scenario di grande incertezza su quali potranno essere le tecnologie vincenti. Sebbene le batterie agli ioni di litio continuino a dominare il mercato e le batterie al sodio-zolfo o quelle a flusso suscitino l’interesse della ricerca e dei grandi gruppi industriali, diverse tecnologie di tipo meccanico come l’accumulo gravitazionale, l’aria compressa, i pompaggi in impianti idroelettrici e i volani si preparano a lanciare la loro sfida in un contesto che potrebbe rivelarsi estremamente competitivo.
I sistemi di pompaggio, di cui l’Italia è già ampiamente dotata, potrebbero da subito rappresentare un importante competitor per i sistemi al litio. L’UE ospita 44 GW di impianti idroelettrici mediante pompaggio, ovvero un quarto della capacità installata globale. I bacini idroelettrici europei forniscono una capacità di stoccaggio di 220 TWh.
Per gli accumuli di breve durata, tuttavia, la tecnologia agli ioni di litio la farà da padrona insieme ad una parte marginale di tecnologie alternative, se opportunamente sovvenzionate o valorizzate.
Diverse sono le prospettive per gli accumuli di lunga durata, dove in questo momento, non vi è una chiara ed univoca definizione del lasso temporale, che in molti casi non supera le 24 ore. La maggior parte delle tecnologie Long-duration energy storage (LDES), alternative all’idroelettrico, sono ancora in fase iniziale di sviluppo e hanno costi variabili. Ma alcune sono già competitive con il litio, per periodi di stoccaggio lunghi.
Inoltre, i costi unitari della maggior parte di queste soluzioni diminuiscono via via che cresce la taglia dell’impianto, quindi l’accumulo di lunga durata può essere scalato in modo più efficiente rispetto al litio, dove invece gli aumenti dei costi sono più lineari e quindi penalizzano le aggiunte di molteplici ore di funzionamento.
La creazione di reti di scambio, come quelle previste nelle Comunità Energetiche, porterà anche alla disponibilità di sistemi di accumulo distribuiti. Questo richiederà tempi ed investimenti nelle tecnologie sopra descritte e l’implementazione di politiche adeguate che abbiano una pianificazione strategica a lungo termine. Tali reti potrebbero iniziare ad essere operative in modo efficace in prossimità del 2030, con ulteriori sviluppi e ottimizzazioni fino al 2050.
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) prevede che l’Italia debba incrementare significativamente la sua capacità di stoccaggio per bilanciare l’intermittenza delle fonti rinnovabili, con una capacità di accumulo stimata tra 6 e 8 GWh entro il 2030.
Mentre entro il 2050, le attuali previsioni indicano la necessità di superare i 20 GWh di capacità di accumulo per sostenere una rete elettrica basata prevalentemente su fonti rinnovabili. L’integrazione dei veicoli elettrici collegati alla rete, attraverso tecnologie come il Vehicle-to-Grid (V2G), potrebbero ridurre significativamente il fabbisogno di sistemi di accumulo tradizionali entro il 2040, contribuendo alla stabilità della rete durante le fluttuazioni della domanda.
pv magazine e Green Horse Advisory sono certi che le loro due sessioni verticali a NetZero Milan, organizzate da Fiera Milano, faranno luce su tutte le questioni critiche discusse sopra, con esperti del mondo accademico, industriale, finanziario e del settore fotovoltaico che forniranno approfondimenti sulla complessità e sulla portata della transizione energetica.
Giovedì 27 marzo
Incontro informale con il Commissario europeo per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, Piotr Serafin, sul prossimo Quadro finanziario pluriennale
Prossimi temi che verranno trattati in Parlamento:
Martedì 8 arile
Road to NetZero Milan webinar: Accumuli elettrochimici per l’industria e la rete elettrica Iscriviti qui
Giovedì 27 marzo
Consiglio Ambiente (ENVI). Discussione sugli aspetti ambientali del Clean Industrial Deal – link
Lunedì 7 aprile
Consiglio Affari esteri (Commercio) – link
Venerdì 11 aprile
Eurogruppo – link
Venerdì 11 e sabato 12 aprile
Riunione informale dei ministri dell’UE per gli Affari economici e finanziari e dei governatori delle banche centrali (ECOFIN) – link
Lunedì 14 aprile
Consiglio Affari esteri – link
Martedì 25 e mercoledì 26 marzo
Petersberg Climate Dialogue (Berlino, Germania)